Presentato a inizio maggio, l’“Atlante di genere di Bologna per una città femminista” indaga su come le differenze di genere influiscono sull’esperienza urbana delle persone. Utilizzando dati disaggregati per genere e mappe tematiche, il volume si propone di far emergere gli usi differenziati della città e contribuisce a evidenziare alcune disuguaglianze che richiedono interventi mirati. Diversi i gruppi marginalizzati presi in considerazione nell’opera, ma non le donne con disabilità.
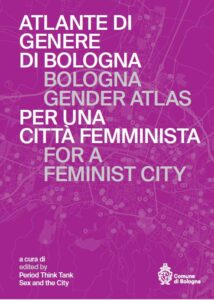
Gli ingredienti c’erano tutti: l’approccio di genere e il riferimento al Femminismo. Non un Femminismo qualsiasi, quello intersezionale, che riconosce come molte donne possano essere discriminate sulla base di più fattori, e come questi possano interagire tra di loro creando un effetto esponenziale sulle disuguaglianze. Ce n’era abbastanza per costruirci sopra un castello di aspettative, per sperare che questa volta le donne con disabilità non sarebbero state ignorate. E invece no, l’Atlante di genere di Bologna per una città femminista, che sintetizza gli esiti di un progetto scaturito dalla collaborazione tra l’Ufficio Pari Opportunità del Comune di Bologna, e le Associazioni Period Think Tank di Bologna e Sex & the City di Milano, ci riporta alla triste realtà.
Presentato a inizio maggio, l’Atlante di genere di Bologna per una città femminista indaga su come le differenze di genere influiscono sull’esperienza urbana delle persone. Esso è stato pubblicato nella versione bilingue italiano/inglese, ed è liberamente fruibile e scaricabile dal sito del Comune di Bologna a questo link. Utilizzando dati disaggregati per genere e mappe tematiche, il volume si propone di far emergere gli usi differenziati della città e contribuisce a evidenziare alcune disuguaglianze che richiedono interventi mirati. In specifico sono trattati in prospettiva di genere i seguenti temi: la sicurezza nello spazio pubblico (reale e percepita); la rete di servizi a supporto della vita quotidiana: tra cui figurano anche i servizi educativi per l’infanzia, quelli per le caregiver che si dedicano alla cura di persone con necessità di sostegno intensivo, nonché l’accesso alla salute ed ai servizi sanitari; la mobilità e le iniziative intraprese per promuoverla, tenendo presente la sostenibilità ambientale; l’abitare e l’accesso alla casa; la toponomastica cittadina ancora sbilanciata rispetto alla rappresentanza femminile; il sex work. Un lavoro articolato in sei sezioni tematiche, dove la parte descrittiva è accompagnata da mappe dettagliate, corredate di fonti, legende e QR code.
«Di chi è la città? Chi ha diritto di viverla in sicurezza e autonomia? Quali corpi sono accolti e quali invece respinti? Bologna, con la sua storia di innovazione sociale, offre un terreno fertile per studiare l’intersezione tra genere e altre variabili come, per esempio, classe sociale, provenienza, età, condizione di disabilità e orientamento sessuale. Tuttavia, il pregresso non deve indurre a un atteggiamento di conservazione, ma rappresentare uno stimolo per raggiungere nuovi traguardi nella lotta alle disuguaglianze», è scritto nell’Introduzione a cura di Period Think Tank e Sex & the City (pag. 13, grassetti nostri nella citazione). Ma in concreto nel volume di disabilità se ne parla solo in relazione al caregiving. Può bastare? La scelta di coinvolgere le donne caregiver nel lavoro di studio e rilevazione è certamente apprezzabile, ma è bene chiarire che le istanze di queste donne, anche se possono avere dei punti di contatto con quelle delle donne con disabilità, non sono sovrapponili ad esse. Infatti, opportunamente, in un altro prezioso (e raro) progetto su temi analoghi – Stare di casa nella città, svolto a Ravenna nel 2016, promosso dall’Associazione Liberedonne che gestisce la Casa delle donne di Ravenna e finanziato dal Comune (di cui si può leggere a questo link) – sono state coinvolte sia le donne con disabilità, sia le madri di figli e figlie con disabilità. Il motivo è semplice: chi presta assistenza ad una persona disabile e chi vive l’esperienza della disabilità sulla propria pelle non vedono il mondo dalla stessa angolazione.
Questa lacuna è ancora più straniante se si pensa che, se non il primo, certamente uno dei primi convegni italiani sulla discriminazione multipla subita dalle donne con disabilità si è tenuto proprio a Bologna più di trent’anni fa. Si intitolava Al silenzio, all’imbarazzo, all’invisibilità: tra femminile e handicap e venne organizzato nel 1991 dall’AIAS di Bologna (Associazione Italiana Assistenza Spastici) in collaborazione con il Progetto Donna del Comune ospitante. In quella occasione venne anche presentato il cortometraggio (della durata di 17.44 minuti) “Non sto parlando di nessun’altra”, realizzato dalla regista Maria Cristina Lasagni, e curato da un gruppo di donne con disabilità del Centro Documentazione Handicap e della stessa AIAS bolognese, anche questo primo nel suo genere (esso è stato messo online nel 2024 ed è liberamente visibile a questo link). Un convegno quasi omonimo venne organizzato, sempre dall’AIAS di Bologna, nel 2007: “Al silenzio…, all’imbarazzo…, all’invisibilità. Tra femminile e disabilità” (i cui atti, a cura di Valeria Alpi, sono pubblicati a questo link). Qualche anno più tardi, «HP Accaparlante», la rivista del Centro Documentazione Handicap di Bologna, che nel 2015 era edita da Quinta di copertina, pubblicò la monografia La vie en rose. Donne con disabilità: inventare e gestire percorsi di uscita dalla violenza («HP Accaparlante», n. 2, 2015). Nel 2017 si è svolto Voci di Donne. Un’analisi delle barriere che le donne con disabilità incontrano nella loro vita, un altro progetto ideato e promosso dall’AIAS di Bologna, e co-finanziato dalla Fondazione del Monte e dalla Commissione Europea (RISEWISE- Horizon 2020), se ne legga a questo link. Nel maggio del 2020, in piena pandemia da Covid-19, l’Associazione MondoDonna Onlus e l’AIAS locale inaugurano lo Sportello CHIAMA chiAMA, un servizio di supporto per donne con disabilità vittime di discriminazione e/o violenza del territorio bolognese, e negli ultimi anni anche la Casa delle donne per non subire violenza, sempre a Bologna, ha iniziato a porsi il problema di rendere i propri spazi e servizi adeguati anche alle esigenze delle donne con disabilità (se ne legga a questo link). Ma non basta, infatti va tenuto presente che nel 2018 La Commissione assembleare per la parità e per i diritti delle persone della Regione Emilia-Romagna ha approvato all’unanimità la Risoluzione 5844 che «impegna la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle differenze di genere e la questione della “discriminazione multipla”, che colpisce le donne con disabilità, nella programmazione nelle proprie politiche sulla disabilità, anche avvalendosi degli spunti offerti dal “Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell’Unione Europea”. A diffondere la conoscenza del suddetto Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, affinché si diffonda l’ottica di genere nell’approccio alle problematiche legate alla disabilità. A proseguire nell’impegno a tutto tondo contro la violenza sulle donne, che merita di essere affrontata e debellata in ogni sua forma e circostanza, avendo con ciò riguardo ad un approccio che sappia tenere in debito conto anche l’eventuale condizione di disabilità della vittima».
Ma ovviamente il tema non è solo “locale”, perché l’Italia (con la Legge 18/2009) ha ratificato la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che alle questioni di genere legate alla disabilità attribuisce un grandissimo rilievo. Tanto che, nel 1016, il Comitato ONU per i diritti delle persone con disabilità, l’organo indipendente proposto a monitorare l’attuazione della menzionata Convenzione, ha espresso preoccupazione perché nel nostro Paese «non vi è alcuna sistematica integrazione delle donne e delle ragazze con disabilità nelle iniziative per la parità di genere, così come in quelle riguardanti la condizione di disabilità», ed ha raccomandato «che la prospettiva di genere sia integrata nelle politiche per la disabilità e che la condizione di disabilità sia integrata nelle politiche di genere, entrambe in stretta consultazione con le donne e le ragazze con disabilità e con le loro organizzazioni rappresentative» (punti 13 e 14 delle Osservazioni Conclusive al primo rapporto dell’Italia sull’applicazione della Convenzione ONU).
Viene da poi osservare che esiste un filone di studi, i Feminist Disability Studies, che si colloca proprio nel solco del Femminismo intersezionale, lo stesso paradigma assunto come riferimento nell’Atlante di genere di Bologna per una città femminista, cosa che rende ancora più incomprensibile la mancanza di attenzione nei confronti delle donne con disabilità.
Nell’Atlante di genere, tra le altre cose, è evidenziato come uno dei passaggi rilevanti che hanno portato alla stesura del volume è dato dalla realizzazione del progetto Verso un atlante di genere. Prospettive femministe per costruire città sicure, che ha previsto varie azioni ed ha prodotto diversi strumenti (tutto il materiale documentario è fruibile da questo link). Tra gli strumenti prodotti vi è anche una brochure antiviolenza denominata La città può aiutarti a liberarti dalla violenza. Una mappa per dire basta!, che è frutto della collaborazione tra il Comune di Bologna, la Città metropolitana di Bologna, i Centri antiviolenza, i Centri per uomini autori di violenza, i Centri antidiscriminazione e antiviolenza LGBTQIA+. Detta brochure è stata tradotta (ed è scaricabile) in quindici lingue (italiano, inglese, bengali, ucraino, spagnolo, russo, rumeno, albanese, urdu, francese, portoghese, vietnamita, arabo, tigrino e farsi). «Nella brochure sono elencati e mappati i sei Centri antiviolenza (Cav) e i relativi sportelli, i due Centri per uomini autori di violenza (Cuav), cui si aggiunge un gruppo di auto-mutuo aiuto dedicato, e i tre Centri della rete di associazioni LGBTQI+, specializzati nel settore del sostegno e dell’aiuto a chi subisce discriminazione o violenza fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Per ogni Centro vengono fornite indicazioni nel dettaglio sui servizi offerti, contatti, orari e modalità di accesso», è scritto nel testo di presentazione. Ebbene, ritenendo questo strumento molto importante, abbiamo analizzato il testo della brochure antiviolenza per vedere se ed in che modo fosse stata considerata la disabilità e se fossero previsti accorgimenti di accessibilità ai contenuti. La prima cosa che notiamo è che, tra le tante traduzioni proposte, non è presente una versione in linguaggio facile da leggere o in comunicazione aumentativa alternativa (CAA), dunque chi, per diversi motivi, non riesce a fruire dei testi in linguaggio comune difficilmente potrà accedere ai contenuti. Riguardo alla descrizione del Centri Antiviolenza apprezziamo molto che per la già menzionata Casa delle donne per non subire violenza sia evidenziata anche la possibilità di videochiamata in LIS (lingua dei segni italiana), e che in generale siano indicati i diversi canali di accesso ai servizi (telefono, whatsapp, e-mail, sito), lasciando così alle donne (disabili e non) la possibilità di scegliere il canale di comunicazione più agevole per loro. Ed apprezziamo anche che sia stato segnalato che CHIAMA chiAMA svolge anche un servizio di sportello antiviolenza per donne con disabilità e di sportello mobile per donne senza dimora. Tuttavia non è evidenziato che anche il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking, ha un accesso multicanale, per cui, chi non può o non vuole utilizzare il telefono, può usare la chat. Dettagli! Si dirà, mica tanto, se vengono omesse informazioni che per alcune donne sono fondamentali al fine valutare se possono accedere a un dato servizio oppure no.
Si sentono sicure le donne con disabilità quando si spostano nell’ambiente urbano? Riescono a utilizzare in autonomia i mezzi di trasporto, i servizi sanitari o d’altro tipo? Non lo sappiamo, perché queste domande non sono state loro rivolte. E a livello simbolico: quanto e come sono rappresentate le donne con disabilità nelle aree urbane? I loro corpi sono accolti o respinti? Sembra che spesso siano ignorati, quasi fossero invisibili. La triste realtà è che sia le Istituzioni sia i Soggetti che si richiamano al Femminismo intersezionale si sono scordati delle donne con disabilità contribuendo, ancora una volta, a invisibilizzarle. Si chiama abilismo, è un sistema oppressivo quanto il patriarcato, il razzismo, il classismo, l’omo-lesbo-transfobia, la grassofobia, l’ageismo, ecc. Sarebbe ora di iniziare ad occuparcene.
Simona Lancioni
Responsabile di Informare un’h – Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli di Peccioli (Pisa)
Si ringrazia Andrea Pancaldi per la segnalazione.
Vedi anche:
Online uno dei primi video di donne con disabilità in Italia: “Non sto parlando di nessun’altra”, 12 marzo 2024.
Emilia-Romagna, prima regione ad adottare il Manifesto delle Donne con Disabilità, 11 maggio 2018.
“Voci di Donne”: dalla parola ai percorsi di libertà, 19 febbraio 2018.
Donne e disabilità, i risultati del progetto “Stare di casa nella città”, 5 dicembre 2016.
Violenza sulle donne con disabilità, il filo del discorso. Recensione de «La vie en rose», 19 novembre 2015.
Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “La violenza nei confronti delle donne con disabilità”.
Sezione del centro Informare un’h dedicata al tema “Donne con disabilità”.
Data di creazione: 18 Maggio 2025
Ultimo aggiornamento il 25 Maggio 2025 da Simona
