di Stefania Delendati*
Ma chi sono i “matti d’Africa”? Sono le persone con patologie psichiche o con epilessia oppure quelle che cercano di restituire loro dignità e futuro in un contesto culturale nel quale la malattia mentale e i disturbi di natura neurologica sono stigmatizzati? Vien da chiederselo leggendo Matti d’Africa. Appunti di viaggio di un medico digitale, libro di Michelangelo Bartolo che spinge a considerare il lavoro di cura da un’angolazione meno scontata e che fa allargare lo spettro delle riflessioni intorno al tema delle “diversità”.
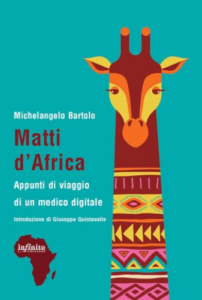
Chi sono dunque i “matti d’Africa”? Sono le persone con patologie psichiche o con epilessia oppure quelle che cercano di restituire loro dignità e futuro in un contesto culturale nel quale la malattia mentale e i disturbi di natura neurologica sono stigmatizzati?
È quello che mi sono domandata leggendo Matti d’Africa. Appunti di viaggio di un medico digitale (Infinito Edizioni, 2025), il nuovo libro di Michelangelo Bartolo. Sono 124 pagine che ci spingono a considerare il lavoro di cura da un’angolazione meno scontata, senza paura di sporcarsi le mani per abbattere le barriere, e alla fine ci costringe, come vedrete, ad allargare lo spettro delle riflessioni intorno al tema delle “diversità”.
L’autore è un medico ospedaliero pioniere della telemedicina, fondatore della Global Health Telemedicine, l’unica piattaforma che mette in comunicazione oltre 50 centri sanitari africani con una rete di più di 200 medici italiani volontari che dal 2013 ha garantito più di 50.000 consulti afferenti a quasi 30 branche specialistiche.
Bartolo, attualmente dirigente dell’Ufficio di Telemedicina della Regione Lazio, da oltre vent’anni compie missioni di cooperazione internazionale con il programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio ed è stato in occasione di uno di questi viaggi che ha conosciuto il “Basaglia d’Africa”, appellativo con cui è noto Grégoire Ahongbonon, un uomo senza particolari competenze sanitarie che da anni libera e cura le persone con malattie mentali, oggi ancora escluse in molti contesti africani, costrette a vivere legate con ceppi e catene ai margini dei villaggi, a volte lasciate morire di inedia, trattate come vittime di sortilegi o possedute, considerate una maledizione per le famiglie e le comunità.
Bartolo e Ahongbonon hanno parecchie cose in comune: sono due uomini sui generis in ogni cosa che fanno, hanno una propensione naturale per abbattere i tabù e aprire strade inesplorate; inoltre abbracciano la fragilità umana in maniera inconsueta. Il primo è un perito che ha scelto un po’ per caso di studiare medicina, senza mai archiviare la cassetta degli attrezzi più adatta a un meccanico che a un medico; il secondo ha un passato da gommista e tassista e dopo avere perso tutto a causa di un incidente, ha trovato la fede e ha deciso di dedicarsi a migliorare la vita delle persone con patologie psichiche e neurologiche. Matti d’Africa racconta l’incontro tra queste due esperienze geograficamente lontane, ma vicine nella sostanza. È un libro impossibile da catalogare in un genere letterario, un diario professionale, un reportage, una biografia, un saggio, tutto contraddistinto da uno stile diretto e intriso di sana ironia, con momenti paradossali che si alternano a quelli toccanti.
In un mondo sempre più interconnesso, ma dove per paradosso le disuguaglianze e le distanze aumentano, Grégoire Ahongbonon affronta la malattia mentale con umiltà e senza pregiudizi, riconoscendo nell’altro, al di là della patologia, le potenzialità inespresse e il bisogno di essere accolto come persona. Michelangelo Bartolo, dal canto suo, è riuscito a dimostrare non senza fatica (lo racconta nei primi capitoli del libro) che si possono mettere in contatto le necessità sanitarie del Terzo Mondo con le competenze mediche europee, un dialogo intercontinentale che unisce scienza e solidarietà, dove la tecnologia diventa uno strumento di incontro e non solo di diagnosi. E l’incontro tra questi due protagonisti principali segna l’inizio di un’avventura. Grégoire va a prendere in albergo Michelangelo e il suo amico Adriano, tecnico esperto di elettroencefalografia. Si presenta in largo anticipo, lasciando interdetti i due italiani, guida in maniera spericolata una vecchia automobile dove lampeggiano numerose spie d’allarme che urlano il bisogno di un controllo in officina. Lui, il “Basaglia d’Africa”, ha più di settant’anni e l’entusiasmo di un ragazzino. Piccolo di statura, porta occhiali dalla montatura esagerata e indossa sempre un gilè multitasche beige. All’inizio degli Anni Novanta avvicina un uomo che rovista tra i rifiuti, lo sguardo perso e i gesti disarmonici non lasciano dubbi, è una persona con disturbi mentali. È una vera e propria folgorazione: da allora, infatti, Grégoire cerca quelli che definisce “gli ultimi degli ultimi”, donne, uomini, bambini e bambine che tutti temono perché hanno comportamenti incomprensibili. Trasforma la sua Associazione Saint Camille de Lellis, fino ad allora un gruppo di preghiera, in un’organizzazione per la tutela della salute mentale.
Nel 1993 vengono aperti i primi centri residenziali di cura e accoglienza, una rete che nel tempo si è diffusa in Benin, Costa d’Avorio, Togo e Burkina Faso, specializzandosi nell’inclusione sociale e lavorativa delle persone che hanno un disagio psichico. Un disagio di cui a volte è difficile capire la causa poiché mancano le strumentazioni necessarie. Ed è qui che entrano in gioco Michelangelo Bartolo e Adriano, per mettere in funzione un apparecchio per elettroencefalogramma che giace inutilizzato in uno dei centri fondati da Grégoire. Devono successivamente collegarlo in rete per i consulti a distanza e formare il personale locale per il suo corretto utilizzo. Se tutto funzionerà, sarà possibile, ad esempio, diagnosticare con certezza l’epilessia, patologia enormemente in crescita in Africa, con 25 milioni di soggetti, per lo più bambini e bambine, che la manifestano. Ma se non c’è una diagnosi chiara, la malattia viene scambiata per una possessione demoniaca o qualcosa di simile, cosicché ancora una volta al posto della cura scattano la superstizione e la conseguente segregazione.

È la prima volta che Michelangelo collega uno strumento di questo tipo alla piattaforma di telemedicina ed è anche la prima volta che si trova a contatto con realtà come i centri sanitari della Saint Camille de Lellis. Sono sette in tutto, ognuno ospita da 120 a 300 persone che, all’arrivo, ricevono una prima diagnosi da uno psichiatra o da un infermiere specializzato e, se necessario, viene prescritta una terapia farmacologica. Gli assistenti sono quasi esclusivamente ex pazienti che, grazie all’esperienza acquisita, contribuiscono a creare un ambiente rassicurante. L’obiettivo è far tornare gli ospiti nelle comunità di origine, magari dopo avere seguito un corso di formazione professionale per il reinserimento sociale e l’autonomia anche economica. Una rete di ambulatori garantisce la prosecuzione delle cure e visite di controllo periodiche.
Punto di riferimento è il Centro di Tokan, in Benin, una struttura che al proprio interno comprende una sartoria, un laboratorio d’arte che produce souvenir e uno di musica che accompagna le funzioni religiose, una cucina, un orto per il sostentamento della comunità e una panetteria. Vi soggiornano circa 300 persone con diversi tipi di disagio psichico, il servizio ambulatoriale ne segue più di 15.000. La maggior parte di loro sono state liberate dalla forzata emarginazione, Grégoire si è recato fisicamente nei villaggi e armato di tronchesi ha tagliato le catene. In questo modo è iniziato il ritorno alla vita di oltre 100.000 persone dal 1994 ad oggi.
C’è una regola imprescindibile in ogni centro per accettare i nuovi ospiti, una regola che dovremmo imparare anche noi: ogni paziente dev’essere accompagnato da un caregiver che, soprattutto nei primi giorni, segue l’inserimento nella struttura. Michelangelo è testimone dell’arrivo di Janet insieme alla figlia che l’assisterà nel percorso di rinascita. Anche questa vicinanza della famiglia è uno dei motivi che hanno fatto superare a Grégoire Ahongbonon i confini africani: tanti psichiatri occidentali, infatti, sono attratti e si confrontano con il suo modello di cura.
Stupisce che questo modello così aderente alle caratteristiche delle singole persone e così attento all’inclusione sociale sia nato in un continente ancora legato a credenze ancestrali, dove anche a causa della povertà, è difficile accedere alle analisi cliniche, all’assistenza sanitaria, alle terapie farmacologiche.
La storia del riconoscimento dei diritti delle persone con patologie mentali in Africa comincia nel 1958 in Nigeria, quando agli sgoccioli del colonialismo britannico viene varato il Lunacy Act, la “Legge sui lunatici”, un nome che è tutto un programma per la prima normativa che disciplina il trattamento dei pazienti con disturbi psichiatrici. È mossa da quello che si potrebbe definire un “non principio”, ovvero non esiste cura, non ci possono essere interventi terapeutici, è prevista soltanto la detenzione degli “idioti”, termine utilizzato per descrivere chiunque ha una disabilità intellettiva.
Dopo due vani tentativi di riforma, nel 2023 questa norma è stata sostituita dal Mental Health Act, una legge che tutela i diritti delle persone con patologie mentali, vieta le discriminazioni anche in ambito lavorativo e tutela l’accesso all’assistenza medica. Tutto questo sulla carta, perché il timore è che le buone intenzioni si incaglino nei limiti delle risorse finanziarie e nei soliti preconcetti culturali.
I problemi di salute mentale in Africa – è un dato di fatto – riguardano quote crescenti della popolazione, aumentate ulteriormente dopo la pandemia. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il disagio psichico colpisce circa 116 milioni di persone nel continente rispetto ai 53 milioni del 1990. A fronte di questo dato, sempre l’OMS stima che sia disponibile soltanto uno psichiatra ogni 500.000 abitanti, una media inferiore di cento volte a quanto si raccomanda. Il World Economic Forum calcola che i governi africani investono in media l’1% o meno del proprio budget sulla salute mentale, il che equivale a 46 centesimi di dollaro USA per persona nel 2022, ben al di sotto dei due dollari consigliati dall’OMS. A mancare sono anche il personale sanitario e i servizi dedicati che anziché aumentare sono diminuiti.

La rivista scientifica «Journal of Global Health» ha pubblicato uno studio secondo cui il tasso medio di posti letto per persone con problemi psichiatrici nell’Africa subsahariana è calato dai 3,2 ogni 100.000 abitanti del 2000 ai 2,2 del 2020. Un dato drammatico, se si pensa che l’Africa registra il più alto tasso di suicidi al mondo, 11 ogni 100.000 persone, e che spesso questa emergenza viene affrontata con la repressione politica.
Proprio in Nigeria, il Paese che ha varato da due anni il citato Mental Health Act, il tentativo di togliersi la vita è punito con un anno di carcere. Il rapido cambiamento sociale in atto contribuisce alla creazione di nuovi modelli antropologici e comportamenti più competitivi. Per molti è difficile stare al passo delle mutate aspettative, cresce l’abuso di alcol, segnale premonitore della depressione, e le famiglie non riescono a identificare i segni del disagio; quando poi ci riescono, non lo percepiscono come curabile e l’allontanamento della persona rimane la “soluzione” privilegiata.
Ormai è assodato che l’assistenza alla salute mentale sia una priorità di salute pubblica nel continente africano che l’OMS ha deciso di sostenere, riunendo, nell’agosto 2022, i Ministri della Sanità e fissando nuovi obiettivi: entro il 2030 tutti i Paesi africani dovranno avere una politica e una legislazione sulla salute mentale, il 60% dovrà averla attuata e l’80% dovrà avere un budget dedicato.
Mentre i governi con le loro tempistiche cercano di porre rimedio, Grégoire Ahongbonon dal canto suo continua la missione di una vita, “liberare i matti”, lavorare con loro e per loro, rendendoli a loro volta “curatori” di altri pazienti psichiatrici, trasformando la guarigione in servizio e risorsa per l’intera comunità.
La lezione di Grégoire ha diverse chiavi di lettura, a mio parere. Se come italiani e italiane dobbiamo sentirci orgogliosi del soprannome di “Basaglia d’Africa”, dobbiamo interrogarci su quanto noi qui nel nostro Paese abbiamo saputo imparare dai fondamenti che nel 1978 portarono alla chiusura dei manicomi. Quali alternative umanamente e dignitosamente accettabili siamo riusciti a costruire per le persone con patologie mentali e le loro famiglie? Ben poche, e intanto c’è chi inquadra Basaglia come «un utopista ovviamente di sinistra, perfettamente impermeabile alla realtà, che con la legge 180 ha inguaiato migliaia di famigliari di malati di mente che da allora devono improvvisarsi psichiatri domestici, e magari impazzire pure loro» e invoca la riapertura dei manicomi, l’isolamento forzato, l’ideologia del “chiudiamoli in un posto”, buttiamo via la chiave e dimentichiamoci che esistono (è la preghiera di Camillo Langone sul «Foglio» del 10 luglio scorso: lui la definisce proprio “una preghiera”).
La malattia mentale risveglia il nostro naturale istinto a respingere ciò che è “diverso”, è il modo in cui la società moderna tratta “l’altro”, sia esso una persona con disturbi psichici, una persona con disabilità, una persona omosessuale, uno straniero e via differenziando, dimenticando che ognuno di noi è “diverso”, ognuno è “straniero” per qualcun altro.
*Direttrice responsabile di «Superando», la testata su cui il presente testo è già stato pubblicato. Esso e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.
Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2025 da Simona
