del Coordinamento PERSONE*
Il bello dell’immaginazione è che ci consente di esplorare il nostro essere nel mondo senza esporci a particolari rischi, ma uscendone in qualche modo trasformati/e. L’immaginazione ci consente, ad esempio, di comparare realtà che mortificano l’individuo, con altre realtà in cui l’individuo è messo in condizione di esprimere sé stesso. È questa la suggestione trasformativa che ci offre il Coordinamento PERSONE in questo nuovo contributo che aggiunge ulteriori elementi di riflessione all’importante confronto pubblico – attualmente in corso – in tema di istituzionalizzazione delle persone con disabilità.
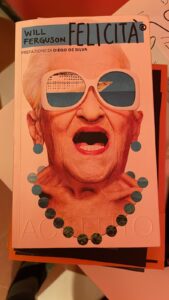
Proviamo a ragionare COME SE il dibattito sulla deistituzionalizzazione non esistesse, COME SE non ci fossero la Convenzione ONU [si riferisce alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, N.d.R.], la Legge Delega [si riferisce alla Legge Delega 227/2021 in materia di disabilità. N.d.R.] etc etc etc.
Cosa rimane? Direte voi.
Rimane la persona e cioè la vera complessità.
Vi chiediamo uno sforzo di fantasia, leggete queste parole COME SE si parlasse di voi, di ognuno di voi.
Cosa sarebbe della vostra vita se, per una qualsiasi vostra caratteristica, qualcuno si arrogasse il diritto di decidere per voi con chi dovete trascorrere il tempo, dove lo dovete trascorrere, facendo cosa?
Se vi dicessero che la vostra vita si svolgerà in un unico posto, fuori dal mondo e dalla comunità di cui fate parte, in cui farete tutto: mangiare, dormire, “socializzare”, fare lavoretti (naturalmente non retribuiti), come la prendereste?
Ecco. Questo è il punto. La Convenzione ONU non ripete 36 (???) volte la frase «su base di uguaglianza con gli altri» perché chi l’ha elaborata era a corto di sinonimi, lo fa perché quella frase significa che anche le persone con disabilità hanno diritto di vivere nel mondo, con gli altri e per qualcosa.
Ci sostiene in questo uno dei massimi esistenzialisti, Martin Heidegger [filosofo tedesco vissuto dal 1889 al 1976, N.d.R.] che prendiamo a prestito in forma semplificata ma efficace.
«Martin Heidegger sosteneva che l’essere umano non può essere compreso separatamente dal mondo in cui vive. La nostra esistenza è caratterizzata da un coinvolgimento diretto e immediato con l’ambiente circostante, che influenza profondamente il nostro modo di essere e di percepire».
Quindi se l’ambiente circostante influenza il nostro modo di essere, significa che dove vivo e con chi vivo non è una questione neutra.
Le tre dimensioni dell’essere-nel-mondo di Heidegger sono:
- Essere-nel (mondo): questo aspetto sottolinea che l’essere umano è sempre situato in un contesto specifico. Non siamo spettatori distaccati, ma partecipanti attivi che interagiscono con l’ambiente e gli oggetti che ci circondano. Questa dimensione ci ricorda che il nostro essere è radicato in un mondo di significati e relazioni che danno forma alla nostra esistenza.
Non siamo spettatori, ma partecipanti attivi. - Essere-con (gli altri): Heidegger riconosce che l’essere umano è intrinsecamente sociale. Viviamo in relazione con gli altri e la nostra identità è in parte formata da queste interazioni. L’essere-con implica che il nostro modo di essere è influenzato dalle aspettative, dalle norme e dalle dinamiche sociali che ci circondano.
Dalle dinamiche sociali che ci circondano. Quali possono essere le dinamiche sociali dentro una istituzione se non quelle dello sbilanciamento totale del potere da una sola parte, quella di chi controlla e decide per l’altro? - Essere-per (qualcosa): questa dimensione si riferisce alla finalità e alla progettualità dell’esistenza umana. Viviamo con intenzioni e scopi che danno senso alle nostre azioni e orientano il nostro essere-nel-mondo. L’essere-per rappresenta il modo in cui ci proiettiamo nel futuro e costruiamo il nostro percorso di vita.
Pensatevi chiusi tra quattro muri dove è impossibile essere nel mondo e essere con gli altri. Riuscite ad immaginare il vostro futuro?
Viviamo un tempo insidioso in cui, addirittura, c’è chi chiede la riapertura dei manicomi come se chiedesse un biglietto del tram.
E allora è sull’uomo e non solo sulle leggi (quelle sono, punto) che dobbiamo confrontarci.
«Basaglia – scrive Francesco Foti in un bellissimo libro dal titolo Franco Basaglia. La libertà è terapeutica [People, 2024, N.d.R.] – fu rivoluzionario perché sostenne che per capire la malattia non si poteva prescindere dalla condizione umana della persona, per osservare la quale bisognava per prima cosa abbattere i muri che la rinchiudevano».
Per comprendere la persona dobbiamo abbattere i muri che la rinchiudono.
E ancora: negli anni a Gorizia, «vennero introdotti nuovi farmaci che facilitavano l’abbandono progressivo della contenzione delle persone ricoverate il che permetteva anche di cominciare a distinguere i danni “reali” della loro malattia da quelli dovuti all’istituzionalizzazione».
L’istituzionalizzazione fa danni. Che poi non si vogliano indagare, questa è tutta un’altra questione.
Come dire che dentro o fuori non è la stessa cosa; che quei muri impediscono a quell’essere umano di esprimersi; che rinchiudendo il corpo rinchiudo tutto ciò che quel corpo significa e può significare per sé stesso e in relazione con gli altri.
C’è poi un altro fattore di cui non si rileva traccia e cioè i determinanti sociali ed economici di salute, ovvero l’impatto diretto che le condizioni sociali ed economiche di una persona hanno sulla sua salute.
Racconta ancora Foti: «Occuparsi del rapporto delle persone con la propria comunità, del loro accesso all’istruzione, delle loro condizioni abitative, di quelle lavorative, di quelle ambientali, era quindi non solo necessario, ma essenziale a garantire un’assistenza adeguata. La libertà, per essere terapeutica, doveva anche essere libera dai bisogni».
Tutto questo per dire che, se ascoltassimo le persone con disabilità, la legge potremmo lasciarla ai giuristi per occuparci dei bisogni dei desideri e delle aspettative di ognuno scegliendo tra le due possibilità del “prendersi cura”.
La prima, ci dice ancora Heidegger, è una cura in cui ci si sostituisce all’altro «che viene così spinto via dal suo posto, messo da parte […]. Di un tale prendersi cura l’altro può diventare dipendente ed esserne dominato anche se tale dominio può restare inavvertito a chi lo subisce».
Non è, forse, questa la “cura” dell’istituzione?
L’altra: la possibilità di prendersi cura non per sottrargli la “cura” ma anzi per restituirgliela in quanto tale e per davvero. Questo prendersi cura aiuta l’altro a diventare libero attraverso essa.
Questa è la cura che vogliamo.
Attaccatela finché volete, stravolgetela, chiamatela stupidaggine. Questo non cambierà le cose. La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità non è il frutto di “una notte alcolica”, ma è figlia anche e soprattutto di questo.
Vogliamo parlarne?
*PERSONE – Coordinamento Nazionale Contro la Discriminazione delle Persone con Disabilità
Bibliografia
Francesco Foti, Franco Basaglia. La libertà è terapeutica, People, 2024.
Isiride Lancetti Contemporary.
Martin Heidegger, Essere e tempo, originale: Sein und Zeit, prima edizione 1927, Halle, Germania; edizione italiana a cura di Franco Volpi, traduttore Pietro Chiodi, Longanesi, 2005.
Nota: il Centro Informare un’h è impegnato nel rivendicare la promozione della deistituzionalizzazione e lo stop all’istituzionalizzazione. Temi su cui si è avviato un confronto pubblico. In calce alla pagina Riforma della disabilità: eliminiamo la possibilità di istituzionalizzare le persone (in aggiornamento) sono segnalati i contributi che di volta in volta si stanno susseguendo.
Ultimo aggiornamento il 29 Luglio 2025 da Simona
