di Giampiero Griffo*
La pletora di pubblicazioni sull’inclusione scolastica delle persone con disabilità o fa emergere le criticità diffuse su tutto il territorio nazionale o si limita a produrre strumentazioni tecniche e burocratiche che dovrebbero accompagnare e spesso semplificare le attività degli “addetti ai lavori”. Un recente libro di Alessandra Maria Straniero, affronta invece il tema da un punto di vista culturale e politico, interrogando in profondità il ruolo e le responsabilità degli insegnanti.
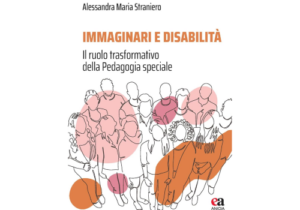
Scrivere un libro sull’inclusione scolastica delle persone con disabilità che apra una riflessione innovativa su due elementi essenziali delle criticità che oggi incontrano gli operatori del settore educativo non è facile. Infatti, la pletora di pubblicazioni sull’argomento o fa emergere le criticità diffuse su tutto il territorio nazionale dei processi di inclusione o si limita a produrre strumentazioni tecniche e burocratiche che dovrebbero accompagnare e spesso semplificare le attività degli “addetti ai lavori”. Il libro Immaginari e disabilità. Il ruolo trasformativo della Pedagogia Speciale (Roma, Anicia, 2025), pubblicato da Alessandra Maria Straniero, ricercatrice di Didattica e Pedagogia Speciale presso il Dipartimento DeMaCS dell’Università della Calabria, affronta invece il tema da un punto di vista culturale e politico, interrogando in profondità il ruolo e le responsabilità degli insegnanti.
Due sono gli approfondimenti tematici che Straniero sviluppa. Il primo è relativo a quale teoria di disabilità sia alla base dell’approccio degli operatori dell’educazione. Il volume analizza infatti ogni modello di disabilità succedutosi nel tempo, modificando progressivamente un approccio millenario che riduceva gli studenti con disabilità – che solo nell’ultimo secolo hanno avuto il riconoscimento al diritto allo studio – alla loro condizione di limitazione funzionale e quindi alla loro impossibilità ad apprendere o ad essere relegati in classi differenziali o scuole speciali, dovendo essere trattati in maniera differente in quanto avrebbero disturbato gli altri alunni nelle classi ordinarie.
Un tema, questo, di recente riproposto nelle stesse forme dal professor Galli Della Loggia, attribuendo a questa scelta le criticità della scuola italiana. Si tratta di un modello medico/individuale ancora prevalente nei modelli di welfare e nelle formazioni degli operatori socio-sanitari.
Ripercorrendo l’evoluzione delle teorie sulla disabilità, il libro fa quindi conoscere come la riflessione sia passata a un modello sociale definito dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Secondo infatti l’articolo 2 di quest’ultima, «per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri».
Questo modello sociale basato sul rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità sposta l’attenzione al contesto in cui vivono queste persone e ai comportamenti discriminatori e inappropriati che ne possono limitare la partecipazione.
Semmai una critica alla ricostruzione di Straniero è quella di avere sottovalutato proprio il tema del rispetto dei diritti umani, che nell’ICF – la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute approvata nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e pensata per obiettivi di analisi demografica – non era stato preso in considerazione.
Questa disamina storica diventa dunque uno strumento culturale essenziale per approcciare gli strumenti e i comportamenti pedagogici ed educativi appropriati. Gli sviluppi successivi delle teorie sulla disabilità (“modello relazionale”, capability approach e “modello di sviluppo umano”) hanno affinato ulteriormente le capacità di analisi della condizione di disabilità, fornendo ulteriori elementi utili ai processi di inclusione educativa. Quanto la conoscenza di questa evoluzione di modelli è conosciuta dagli insegnati e dagli operatori educativi che operano nelle scuole e nelle università?
Se poi coniughiamo questa carenza culturale con i processi che da millenni hanno costruito uno stigma negativo verso le persone con limitazioni funzionali risulta evidente come tali processi influenzino gli insegnati e le altre figure professionali che operano nelle scuole italiane.
Partendo dal concetto di habitus elaborato dal sociologo francese Pierre Bourdieu – inteso come il senso comune che costituisce la base culturale delle comunità in cui le persone vivono – e dalla definizione di Alessandra M. Straniero della «concezione profonda che gli insegnanti hanno della disabilità come fenomeno umano, sociale e pedagogico», il volume utilizza nuovi strumenti di analisi per indagare il sostrato culturale che orienta i comportamenti di 1.368 insegnanti in formazione sui temi della disabilità e dell’inclusione. L’indagine fa emergere gli immaginari negativi e stigmatizzanti che influenzano la loro visione sulle persone con disabilità e sul modo in cui queste dovrebbero essere considerate nei processi educativi. Sulla base di semplici domande sul tema della disabilità e dell’inclusione, la ricerca ricostruisce, sulla base delle parole e degli aggettivi utilizzati nelle risposte, l’immaginario che guida il lavoro di inclusione e la lettura della condizione di disabilità. Gli elementi che emergono fanno capire quanto sia introiettato lo stigma negativo millenario e come questo approccio culturale influenzi gli insegnanti nel loro lavoro quotidiano, nell’uso degli strumenti tecnici e pedagogici.
Le conclusioni di Straniero indicano alcuni percorsi per costruire un profilo di docente inclusivo. L’elemento più importante è la capacità di formare gli insegnanti sull’habitus professionale adeguato ad affrontare correttamente il lavoro di inclusione educativa. Tale habitus deve basarsi su una capacità riflessiva, come dispositivo della costruzione dell’identità dell’insegnante, che sia consapevole delle eredità culturali che ne influenzano il lavoro, accompagnata da considerazioni che hanno a che vedere con la formazione sull’inclusione, le relazioni umane e tecniche con gli studenti e gli operatori educativi che operano nelle scuole.
* Condirettore del CeRC (Centre for Governmentality and Disability Studies “Robert Castel”) dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il presente testo è già stato pubblicato sulla testata «Superando», e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al diverso contesto, per gentile concessione.
Ultimo aggiornamento il 3 Novembre 2025 da Simona
