Nonostante l’istituzionalizzazione risulti essere illegittima, perché in contrasto con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, è abbastanza infrequente che le persone comuni la connotino come una pratica discriminatoria. Lo scritto propone alcune evidenze che possono contribuire a ridurre lo scollamento tra la realtà del fenomeno e la percezione alterata dello stesso.
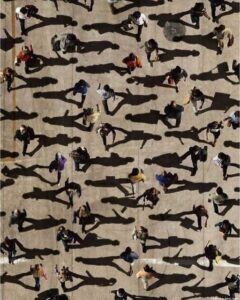
Nonostante l’istituzionalizzazione si configuri come una pratica illegittima, perché in contrasto con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (ratificata dall’Italia con la Legge 18/2009)[1], e nonostante il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità abbia esplicitamente chiesto al nostro Paese di abolirla[2], l’Italia non si è ancora dotata di un Piano Nazionale per la deistituzionalizzazione. Non solo. Nel Decreto Legislativo 62/2024, attuativo della Legge Delega 227/2021 in materia di disabilità, è scomparso qualsiasi riferimento alla deistituzionalizzazione (che invece era presente nella Legge di delegazione), ed è stata introdotta una disposizione che consente che ulteriori persone possano venire istituzionalizzate in futuro[3]. La qual cosa significa che la condizione di disabilità può ancora essere utilizzata come pretesto per privare le persone con disabilità della loro libertà personale, del diritto di vivere nella società con la stessa libertà di scelta riconosciuta alle altre persone, nonché della possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere, senza essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione.
Eppure è abbastanza infrequente che le persone comuni connotino l’istituzionalizzazione come una pratica discriminatoria. Le ragioni dello scollamento tra la realtà del fenomeno e la percezione alterata dello stesso sono molteplici. Tra queste vi sono certamente la scarsa conoscenza e consapevolezza di come realmente funzionino le strutture residenziali per le persone anziane e con disabilità; il pregiudizio, ancora molto diffuso, che le persone disabili debbano vivere in luoghi speciali[4]; l’erronea convinzione che non vi siano alternative all’istituzionalizzazione; la scarsità di studi italiani sul tema dei maltrattamenti all’interno di dette strutture; la tendenza dei media ad occuparsi solo dei casi di maltrattamento più eclatanti (come, ad esempio, le vicende di violenze fisiche, abusi e violenze sessuali, insulti, incuria ecc.), oppure di situazioni eccezionali (quale è stata, ad esempio, la pandemia da Covid-19), ed a trascurare altre forme di maltrattamento meno appariscenti, favorendo, in tal modo, la normalizzazione di queste ultime. Ragion per cui assurgono agli onori della cronaca i casi di maltrattamento intenzionale – quello volutamente posto in essere ai danni di persone anziane e disabili da soggetti preposti a prendersi cura di loro –, mentre resta invisibile il maltrattamento non intenzionale che, scaturendo dalle prassi organizzative proprie delle strutture, risulta invece essere molto più pervasivo e capillare di quello intenzionale. A ciò si aggiunga che difficilmente nei media generalisti vengono considerati aspetti quali l’impatto della standardizzazione dei servizi su chi ne usufruisce; la tendenza alla sanitarizzazione degli stessi; l’asimmetria di potere che caratterizza la relazione tra la persona anziana e/o disabile ospitata nella struttura e chi in quella struttura ci lavora o ha responsabilità gestionali. Tutte questioni fondamentali per chi voglia affrontare questi temi alla luce dei principi sanciti dalla Convenzione ONU.
In questo quadro si rivela particolarmente utile ed illuminate il saggio denominato Il maltrattamento invisibile degli anziani e dei disabili nelle RSA[5] tra quotidianità e normalizzazione, elaborato da Luca Fazzi, professore ordinario di Sociologia presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento, nel 2024[6]. Il saggio è sviluppato facendo riferimento agli esiti di due indagini, una svolta tra il 2018 e la fine del 2020 tra circa 180 dirigenti, operatori e familiari di persone anziane residenti in RSA[7], mentre l’altra, a suo tempo in fase di realizzazione, ha coinvolto un campione di 80 familiari di persone anziane e disabili adulti ricoverati in RSA durante il periodo delle restrizioni introdotte in relazione alla pandemia da Covid-19 nelle Regioni del Nord-Est. In questo testo, per ragioni di spazio, non entriamo nel merito dell’illustrazione delle due singole indagini esaminate nel saggio, ma ci limiteremo a segnalare alcune evidenze emerse dallo studio.
Il primo importantissimo aspetto è che anche lo studio svolto da Fazzi nel contesto italiano «conferma quello che la ricerca empirica internazionale ha da tempo rilevato, ovvero che il maltrattamento è un fenomeno endemico e connaturato all’organizzazione delle cure della gran parte delle strutture residenziali per anziani e disabili adulti» (Fazzi, op. cit. pag. 456, grassetti nostri in questa e nelle successive citazioni testuali). Il riferimento non è al maltrattamento intenzionale e violento di cui di solito si occupano i media (i cui casi, sebbene non numericamente irrilevanti, si connotano come eccezioni), ma ad un maltrattamento che «assume dimensioni molto più estese e drammatiche e ingloba una sistematica e diffusa violazione di diritti personali» (Fazzi, op. cit. pag. 457). In particolare, secondo l’Autore, «la vera epidemia riguarda due forme di maltrattamento più difficili da tematizzare e individuare: quello psicologico emotivo, e l’incuria. La grandissima parte degli intervistati ha ammesso di essere stata o di avere assistito con regolarità nel corso delle proprie attività lavorative quotidiane a episodi di maltrattamento psicologico emotivo e di trascuratezza» (Fazzi, op. cit. pag. 457). Per questo motivo l’Autore ritiene che solo la riflessione su queste tipologie di maltrattamento potrà portare i dirigenti e il personale a divenire consapevoli della gravità del fenomeno. Ciò anche in considerazione dei «troppo alti livelli di scarsa consapevolezza sugli effetti dei comportamenti quotidiani» (Fazzi, op. cit. pag. 457) che diversi studiosi hanno individuato come uno dei problemi alla base dei maltrattamenti. La circostanza che determinate azioni siano poste in essere in modo inconsapevole, senza che vi sia comprensione di cosa sia corretto o meno, non induce chi le compie a prendere in considerazione di poterle modificare. Accade così che «ritardi nella somministrazione di medicinali, visite mediche prorogate a data da definirsi, violazioni sistematiche della privacy, contenzioni protratte e non giustificate, infantilizzazioni» diventino comportamenti ampiamente diffusi e tollerati, e che entrino «a fare parte delle culture organizzative e professionali in modo quasi automatico e irriflesso» (Fazzi, op. cit. pag. 457).
In un altro passaggio l’Autore evidenzia il rischio palese che nelle pratiche quotidiane della cura si assista ad un «processo di “normalizzazione” del maltrattamento» (Fazzi, op. cit. pag. 458) che impedisce che esso venga percepito come tale, ed eventualmente lo consideri come un costo da pagare alle difficoltà di finanziamento e di reperimento di personale qualificato. Ma «la realtà è che molti episodi di maltrattamento quotidiano – la violazione della privacy nelle stanze, le conseguenze della fretta nello svolgimento delle mansioni, l’uso improprio e continuato delle contenzioni, il lasciare le persone inerti negli spazi comuni per ore senza stimolazioni, la scarsa attenzione data alla socialità e al ruolo dei familiari – derivano da qualcosa che va oltre l’organizzazione, ma che l’organizzazione riproduce e istituzionalizza alla massima potenza, ovvero l’idea che la grave fragilità di alcune tipologie di persone sia una forma di “semi-vita”, i cui bisogni possono essere soddisfatti con uno sforzo minimale. Obbiettivi di efficienza e produttività assolutamente legittimi rischiano di essere così utilizzati in modo improprio per mascherare la difficoltà di considerare i disabili adulti e gli anziani nelle strutture come persone con diritti eguali a quelli di qualsiasi altro cittadino» (Fazzi, op. cit. pag. 459).
Nella parte iniziale del presente testo abbiamo osservato come sia abbastanza infrequente che le persone comuni connotino l’istituzionalizzazione come una pratica discriminatoria. Ci auguriamo che le evidenze segnalate possano contribuire a percepire la stessa in modo più aderente alla realtà. Ma anche in assenza di evidenze scientifiche, la linea di demarcazione tra una pratica accettabile e una che non lo è può essere disvelata attraverso una semplice domanda: “la pratica che consideriamo accettabile per le persone disabili e anziane, noi la accetteremmo?”
Simona Lancioni
Responsabile di Informare un’h – Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli di Peccioli (Pisa)
Nota: il Centro Informare un’h è impegnato nel rivendicare la promozione della deistituzionalizzazione e lo stop all’istituzionalizzazione. Temi su cui si è avviato un confronto pubblico. In calce alla pagina Riforma della disabilità: eliminiamo la possibilità di istituzionalizzare le persone (in aggiornamento) sono segnalati i contributi che di volta in volta si stanno susseguendo.
[1] È in contrasto in particolare, ma non solo, con l’articolo 19 (Vita indipendente ed inclusione nella società).
[2] Comitato ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità, Osservazioni Conclusive al primo rapporto dell’Italia sull’applicazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, 31 agosto 2016 (si vedano in particolare i punti 47 e 48).
[3] Si veda il seguente approfondimento: Simona Lancioni, Riforma della disabilità: eliminiamo la possibilità di istituzionalizzare le persone, «Informare un’h», 20 giugno 2025.
[4] Si veda: Simona Lancioni, L’istituzionalizzazione e la “specialità della casa”, «Informare un’h», 27 luglio 2025.
[5] Residenze sanitarie assistite.
[6] Esso è pubblicato alle pagine 447-460 del volume collettivo Il soggiorno obbligato. La disabilità fra dispositivi di incapacitazione e strategie di emancipazione, a cura di Ciro Tarantino, Collana: Percorsi, Bologna, il Mulino, 2024, 672 pagine. Il volume è liberamente fruibile a questo link. Esso è articolato in cinque parti: Geometrie esistenziali e crisi della presenza; Cartometrie e cartografie della residenzialità in Italia; Codici culturali e quadri normativi; Dispositivi di incapacitazione; Strategie di emancipazione). Una sua presentazione è disponibile a quest’altro link.
[7] Luca Fazzi, Il maltrattamento dell’anziano in RSA. Analisi del fenomeno, strumenti per l’individuazione, strategie di prevenzione, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2021.
Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2025 da Simona
